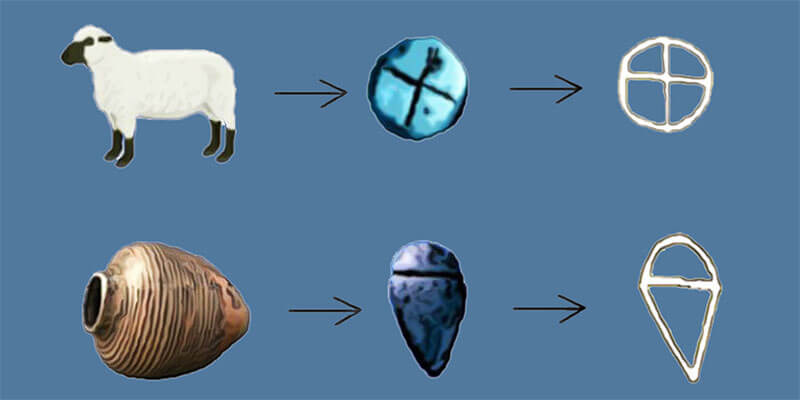Fra i tratti del pensiero junghiano che maggiormente lo caratterizzano, quello che più di altri suscita in me stupore e ammirazione è rappresentato dalla curvatura che Jung imprime al proprio modo di vedere le cose e di intrattenere relazioni con il mondo. Jung è stato sicuramente un grande osservatore della realtà umana, ma gli occhi con cui osservava erano occhi che riuscivano a vedere il mondo ponendosi da una posizione del tutto particolare.
Certamente è una forzatura costringere la ricchezza del suo pensiero, la varietà dei terreni da lui dissodati ad un solo elemento, ad un solo sguardo; tuttavia vi è una determinazione che, a mio avviso, non si lascia porre sullo stesso piano delle altre, in quanto si rivela così costantemente ricorrente che me la rende una specie di filo rosso di tutta la sua copiosa produzione.
Si tratta di questo: Jung ha individuato un processo di conoscenza del tutto particolare e specifico, basato su dispositivi decisamente originali, un processo di conoscenza della psiche che implica una direzionalità a doppio senso, sia da un centro conoscitivo verso un oggetto da conoscere, sia all’inverso dall’oggetto conosciuto al centro della conoscenza. Per Jung ogni procedimento teso alla conoscenza della psiche non può sottrarsi all’effetto retroattivo che questa conoscenza ingenera sul soggetto della conoscenza stessa. Penso che tutti possiamo convenire che questo doppio movimento, se posto alla base, crea una teoria, un metodo e una pratica del tutto particolari. Si tratta di un movimento che non è inconsapevole per lo stesso Jung, non si tratta cioè di argini impliciti e inconsapevoli entro cui noi collochiamo il suo pensiero, poiché Jung stesso era consapevole del significato epistemologico che rivestiva questo suo particolare punto di vista sulla psiche, una consapevolezza che recentemente è stata sottolineata anche, per esempio, da Renos Padoupolos.[1]
Questa curvatura del suo sguardo psichico, che induce una continua dislocazione, non rappresenta per Jung la fine di ogni possibile teoria, ed è mia ferma opinione che dobbiamo diffidare dal considerare le sue numerossissime opere come prodotti slegati di una mente volatile dipendente dagli umori del momento. Lo sforzo costante di Jung fu sempre quello di trovare una coerenza, mantenendo tuttavia l’incoerenza e la casualità dell’esistente, degli esseri umani, dei fatti e delle cose. Il suo sforzo fu sempre quello di rendere ragione di ogni aspetto della realtà umana, di entrare nelle pieghe più nascoste dell’anima, quelle pieghe che possono azzerare qualsiasi costruzione psicologica conciliatoria ed edulcorata, quelle faglie che, aprendo scenari inaspettati, troncano alla radice ogni certezza consolatoria, basata su un procedimento di costruzione lineare della realtà. La teoria di Jung è una teoria attraversata da solchi di non-teoria, interrotta continuamente nella sua progressione lineare, ed interrotta proprio da questo continuo ritorno indietro.
Questo modo di procedere si riflette sui molteplici aspetti delle sue considerazioni più legate alla clinica; così la freudiana relazione di transfert/controtransfert diventa una relazione di transfert/transfert, poiché i movimenti, pur nella dovuta asimmetrica relazione analista/paziente, sono gli stessi; così ogni coloritura affettiva è coinvolta nella teoria che viene espressa, che quindi non potrà mai essere “pura”, ma sarà sempre parzialmente condizionata dagli stati psicologici soggettivi, così come, all’inverso, non vi è stato psicologico esclusivamente emotivo, scevro cioè da qualsivoglia orientamento ideativo. Tentare di separare emozioni e pensiero significa spaccare nuovamente l’essere umano in due metà, proprio nel momento in cui anche le neuroscienze procedono verso una loro considerazione unitaria. Queste considerazioni comportano un punto di vista teorico costantemente oscillante, non ci si potrà mai acquietare nelle posizioni raggiunte e lì dimorarvi stabilmente: la teoria junghiana è una teoria costitutivamente aperta e perennemente in movimento, e forse proprio per questa sua caratteristica può essere applicata con maggiore efficacia nel trattamento delle patologie più gravi.
Questo spezzettamento continuo del discorso opera su almeno due livelli: nel primo esso dimostra di essere più aderente all’andamento della vita stessa e pertanto della stessa psiche; il secondo è che il punto da cui si parte resta sempre impigliato nel percorso che si compie, come a dire che delle origini non si può fare a meno, anche perché l’origine della conoscenza psicologica non è un punto fisso, determinato, eterno ed immutabile ma è esso stesso costituito da un fascio di relazioni e pertanto esso stesso configurato dalle determinanti culturali e dai sedimenti della storia.
Non so se abbiamo appreso fino in fondo l’effetto dirompente che si ha nel costruire una teoria psicologica sul modulo del doppio rimando, quel doppio rimando che è stato magistralmente descritto dal compianto Mario Trevi secondo i due moduli del discorso sulla psiche e del discorso della psiche. Costruire qualcosa su questo fondamento può avere esiti anche differenziati e divergenti a seconda se si attribuisce un maggior valore alla non fondamentalità oppure al fatto che la base fondamentale del pensiero è caratterizzata da un’oscillazione teorica; possiamo cioè essere condotti verso un modo di pensare relativistico, di cui l’ermeneutica è stata e continua ad essere l’espressione teorica più completa e profonda, ma possiamo anche attestarci su un punto archimedeo di grande forza da cui esaminare la psiche in tutte le sue manifestazioni.
Se la teoria ha caratteristiche così peculiari, il metodo che ne discende sarà necessariamente adeguato. Oramai molti anni fa, definii questo particolare metodo che deriva dal particolare sguardo teorico di Jung la metodologia del paradosso, e continuo a pensare che proprio il paradosso ne rappresenta lo schema più proprio.
Secondo il matematico Odifreddi, il termine paradosso, che deriva dal greco ed è composto da parà (contro) e doxa (opinione), «indica una proposizione formulata in evidente contraddizione con l’esperienza comune o con i propri principi elementari della logica ma che, sottoposta a rigorosa critica, si dimostra valida. I paradossi sono smagliature di assurdità nel tessuto della conoscenza: dapprima ci fanno dubitare delle nostre credenze e poi ci spingono a ridefinire i nostri concetti. Alcuni (paradossi) sono antichi quanto la parola, altri sono addirittura preverbali e puramente percettivi. Studiarli e confrontarcisi è un occasione non solo per rimettere in discussione i pregiudizi più radicati, ma anche per scoprire il ruolo che idee semplici e divertenti hanno avuto nello sviluppo delle scienze più disparate, dalla matematica all’economia.»[2]
Ed io aggiungerei anche nello sviluppo della psicologia.
Mi sembra che proprio questo Jung ci spinge a fare, a dubitare costantemente delle nostre credenze e a ridefinire continuamente i nostri concetti, credenze e concetti che di continuo sono spinti al lato dall’incalzare dei fatti della vita. Così Jung, nella pratica clinica, non penserà mai che qualcosa è incomprensibile, nel senso che la categoria dell’incomprensibilità non potrà mai cadere sull’oggetto. Non sono i sogni ad essere incomprensibili, bensì semplicemente siamo noi che non li comprendiamo, e lo stesso vale per i sintomi. Chi vuole conoscere deve sempre piegare la propria mente e dislocarsi per abitare presso ciò che si vuole conoscere. Jung, nella sua pratica clinica, mantiene sempre viva la potenza dirompente del disturbo, di ciò che rompe con il procedere ordinato della coscienza, il cosiddetto disturbo rappresenta un valore inestimabile perché nessuna teoria potrà impedire ai fatti di esistere.
Così anche il metodo della psicologia analitica è anch’esso un metodo spezzato che produce risultati incerti e provvisori ma proprio per questo, ha un valore inestimabile, quello di determinare un contesto entro il quale, e solo entro il quale, potrà trovare strumenti e dispositivi per liberare la propria energia conoscitiva.
Sia pure con estrema cautela, forse possiamo ancora parlare di un’ortodossia freudiana, ma ci è sempre risultato molto difficile sostenere con altrettanta forza che vi sia un’ortodossia junghiana. Se nel pensiero di Freud possiamo forse ancora separare sviluppi ortodossi e sviluppi divergenti, Galimberti per esempio ne prospettava la possibilità[3], la concezione energetica di Jung, in cui il referente oggettuale è variabile e dipendente dall’organizzazione esperienzale di una personalità, ha, tra le altre conseguenze, quella di contestualizzare al massimo grado il luogo dell’espressività psicologica e quindi anche il luogo della sua possibile cura. Paradossalmente, è la concezione teorica antifondativa di Jung quella che si pone quale punto di forza della sua teoria e, proprio per questo, bene si inserisce in un modo di pensare caratteristico di alcuni aspetti della modernità.
Sembra che la ragione moderna abbia oramai dispiegato in tutte le sue sfaccettature la perdita di fiducia incondizionata verso l’esistenza di un nesso logico necessario tra i dati ultimi dell’esperienza e le leggi fondamentali del pensiero razionale per cui la contestualizzazione del pensiero si è imposta contro ogni astrazione e generalizzazione di qualsiasi discorso.
Il tipo di conoscenza della psiche che Jung introduce, fin dai suoi esordi psichiatrici, con la somministrazione del reattivo verbale e con l’applicazione del metodo associativo, presenta alcune caratteristiche che elenco di seguito:
- È una conoscenza relativa a situazioni circostanziali e a contesti delimitati e che trova la propria validità all’interno di questi;
- Esiste un intreccio indissolubile tra la pratica e la teoria e i due piani si modellano reciprocamente;
- I singoli casi clinici non potranno mai beneficiare del diventare teoria, in senso classico, cioè non potranno mai beneficiare di una conoscenza di tipo logico; i singoli casi, messi uno a fianco dell’altro non potranno mai uscire dalla loro singola specificità e diventare una teoria generale.
Gli analisti, nel loro iter conoscitivo, non possono basarsi né su un percorso che dalle affermazioni teoriche di principio passa ai singoli casi, un procedimento cioè deduttivo, né possono procedere nell’accumulo della casistica clinica per trarne conclusioni generalizzanti secondo il metodo induttivo o sperimentale; ma questo non significa che la metodologia del paradosso non possa produrre conoscenza, e non significa neppure che la conoscenza psicologica si debba inquadrare soltanto in un piano narrativo, anche se la narrazione è parte fondamentale dell’organizzazione della psiche.
In questione è quella che viene chiamata teoria della clinica. Di quale teoria allora dobbiamo parlare? E non dobbiamo neppure dimenticare che una teoria della clinica ci è assolutamente necessaria per poter comunicare in modo significativo tra di noi, poiché nel singolo caso clinico portato dal collega non si può entrare più di tanto, né tantomeno possiamo comunicare tra noi sulla base della cattiva filosofia dei massimi sistemi o della metafisica pura; e neppure possiamo parlare condividendo l’impianto scientifico delle neuroscienze.
Vi è un terzo procedimento conoscitivo, oltre a quello induttivo e deduttivo, che si rivela più adeguato alla materia psicologica e pertanto più capace di raggiungere una teoria il più possibile rispettosa della clinica, questo terzo procedimento va ricercato nelle pieghe di un procedimento analogico e nelle concrezioni di una conoscenza paradigmatica.
Enzo Melandri ha ripetutamente mostrato[4] che l’analogia riesce ad aggirare la logica binaria, tutta occidentale, del terzo escluso, anzi fa valere quest’ultimo al massimo grado: così, durante un procedimento analitico, le dicotomie logiche si trasformano in un campo di forze percorso da tensioni polari, ci si trova in presenza di esperienze conflittuali o lacerazioni psicologiche che tendono a perdere le loro identità sostanziali; e, se nel ragionamento teorico classico derivato dalla filosofia greca l’alternativa tra A e B escludeva il terzo, il famoso tertium non datur, in un procedere analogico il terzo lavora al suo massimo grado di potenza; è un terzo che lavora, non come termine omogeneo agli altri due, ma per sottrarre valore identitario ai due termini, per neutralizzarli: il campo di forze dell’analisi che libera energia conoscitiva lo potremmo definire, insieme ad Agamben, il campo degli indiscernibili.
Lo stile di pensiero paradigmatico, dal canto suo, non obbedisce alla logica del trasporto metaforico di un significato, ma a quella analogica dell’esempio; il paradigma è differente dalla metafora: questa infatti estende un significante fino a designare fenomeni eterogenei in virtù di una stessa struttura semantica. Il paradigma è invece “un caso singolo che viene isolato dal contesto di cui fa parte, soltanto nella misura in cui esso, esibendo la propria singolarità, rende intellegibile un nuovo insieme, la cui omogeneità è esso stesso a costruire.”[5]
E, continua Agamben, “Fare un esempio è un atto complesso, che suppone che il termine che funge da paradigma sia disattivato dal suo uso normale, non per essere spostato in un altro ambito [come nella metafora] ma, al contrario, per mostrare il canone di quell’uso, che non è possibile esibire in altro modo.”[6]
Le definizioni di analogia e paradigma mi sembravano particolarmente calzanti a descrivere non solo il nostro lavoro clinico ma anche il modo in cui possiamo parlare di clinica.
Nella mia esperienza di lavoro, mi sono spesso trovata a leggere testi psicoanalitici molto interessanti ma che non riuscivano ad essere attinenti alla mia pratica clinica, per cui, se li utilizzavo, risultavano cappelli giustapposti e scissi,; ugualmente a volte ci si attesta al livello clinico descrittivo e non riusciamo a fare quel salto che ci potrebbe condurre ad un altro piano e all’utilizzo di un metalinguaggio. In questo senso se pensiamo che un esempio clinico abbia un valore paradigmatico, intendiamo che esso funge da esempio comune e si sostituisce alle regole esplicite e permette di definire una particolare e coerente tradizione di ricerca: ogni caso clinico inaugura un filone di ricerca e una conoscenza circoscritta dai contenuti di quel caso, ma, proprio in quanto caso singolo, esso “acquista la capacità di modellare tacitamente il comportamento e le pratiche di ricerca.”[7]
La teoria junghiana può essere accostata allo stile analogico e paradigmatico, si passa dal singolo caso all’altro singolo caso attraverso un procedimento analogico e, senza uscire dalla singolarità, ogni singolo caso è trasformato in esemplare di una regola generale che tuttavia non è mai possibile formulare a priori. Ho pensato che solo questo modo di procedere può offrire un rispetto al massimo grado della unicità e singolarità di ciascun individuo, in quanto se il procedimento deduttivo ne spazzerebbe via le caratteristiche che non entrerebbero in una mente preformata, il metodo sperimentale metterebbe in relazione casistiche incommensurabili tra loro.
Il templum psicoanalitico e la conoscenza paradigmatica
La contemplazione, afferma Didi-Huberman, significa delimitare un templum, ossia costruire un templum divinatorio[8]. Quando si costruisce un tempio, ogni cosa si trasfigura secondo un nuovo sistema di qualità concrete; l’aruspice nel tempio contempla con un’attenzione particolare, per es. il fegato animale, per trarne profezie e vaticini: l’attenzione dell’aruspice non si limita a concentrarsi sull’oggetto per vederlo bene, da vicino, ma implica anche un vederlo diversamente. Vedere diversamente un qualcosa provoca una modificazione decisiva non solo nello sguardo di chi lo orienta ma anche nello statuto di visibilità dell’oggetto quando esso è guardato con attenzione e diversamente.
La stanza dell’analisi è un campo operazionale, un luogo determinato, definito, capace di far concordare, come in un templum, ordini eterogenei di realtà ed anche capace di costruire quella stessa concordanza che rende quel luogo un luogo di sovradeterminazione. Si tratta di stabilire rapporti e costruire nessi che non sono né visibili né evidenti, rapporti e legami che poi possono diventare paradigmatici per una rilettura di sé stessi e, perché no, anche del mondo.
Il titolo che ho dato a queste mie riflessioni prevede un punto interrogativo finale: Jung: un pensiero inattuale(?), non posso infatti fare a meno di chiedermi se il mio discorso pone Jung nella modernità o lo consegna ad un passato oramai perduto. Non so rispondere a questa domanda e forse mi interessa fino a un certo punto potervi rispondere.
Mi piace accostare Jung a un altro pensatore, in tutt’altro ambito e con tutta un’altra storia.
Penso a Piepaolo Pasolini, al suo stile di vita, alle sue riflessioni, ai suoi prodotti artistici. Sempre Pasolini si mise di traverso alla cultura del suo tempo, di destra come di sinistra, colpevole ai suoi occhi di omologare all’interno di una società industrializzata un pensiero che viceversa traeva la sua forza vitale da una società contadina. In questo senso, io penso che la grande costruzione psicologica di Jung è contro ogni omologazione poiché distilla la sua linfa più vitale proprio in quell’unicità che si esprime al meglio nel processo di individuazione.
E, sempre in questo senso, il pensiero junghiano si pone di traverso a molti aspetti dell’organizzazione della nostra società e dei valori della nostra epoca, rivendicando il primato e la centralità del soggetto contro ogni appiattimento sul sociale, centrando la propria attenzione proprio per enucleare e far emergere quegli aspetti che più lo caratterizzano in nome di un’integrità che lo salva.
Contro ogni acritico e passivo conformismo sociale credo che il messaggio di Jung contenga un invito a mantenere sempre aperta e viva la domanda, cioè l’interrogazione della realtà in ogni suo aspetto, un perché che si rivolge a tutte le manifestazione fenomeniche che, per loro natura, sempre si sottraggono a risposte conclusive e definitorie. Una domanda che non risponde ad un arido intellettualismo in quanto sostenuta da sentimenti affettivizzati, perché desituarsi rispetto alle proprie certezze e ai propri punti di vista è un’operazione tutt’altro che banale, e la si compie solo se spinti da qualcosa di molto forte, cioè da un movimento affettivo che si impone nella sua forza.
Per concludere io vedrei in questa epistemologia aperta, caratterizzata da un pensiero paradossale, quale è quello junghiano, la sua grande capacità di poter entrare in risonanza con la cultura del proprio tempo e di stabilire con questa un dialogo continuo che ne assicura così la propria sopravvivenza.
Note
- [1] Renos Papadopoulos, che ha curato e pubblicato un volume collettivo dal titolo Manuale di psicologia junghiana, vi inserisce un proprio lavoro che riguarda i temi dell’epistemologia e della metodologia, sostenendo che “se si leggesse Jung in un certo modo, si scoprirebbero delle importanti intuizioni epistemologiche e metodologiche [e che] quelle intuizioni sono oggi importanti e possono arricchire in modo sostanziale i dibattiti attuali in quei campi”. E, per evitare ogni incertezza verso il suo punto di vista, Papadopoulos conclude il suo scritto con la seguente affermazione: “Jung ha manifestato per tutta la vita e in tutta la sua opera una notevole consapevolezza dei processi epistemologici.”. (Papadopoulos 2009, p. 41).
- [2] Piergiorgio Odifreddi, http://www.intelligiochi.it/IG_paradossi.htm
- [3] Galimberti U., Dizionario di Psicologia, (voce Psicologia del Profondo), UTET, Torino 1992.
- [4] Melandri è stato uno degli autori più completi ad aver valorizzato concettualmente la forza conoscitiva del pensiero analogico. Ricordiamo tra i suoi scritti, in particolare, La linea e il circolo, recentemente ristampato per i tipi di Quodlibet e “I paradossi dell’infinito nell’orizzonte fenomenologico” in (1960) Omaggio ad Husserl.
- [5] Con queste parole Giorgio Agamben difende la conoscenza paradigmatica in quanto unica modalità che può salvare il valore della singolarità. In G. Agamben, Signatura rerum, Bollati Boringhieri, Torino 2008, p. 20.
- [6] ibidem
- [7] ivi, p. 13
- [8] Cfr. G. Didi-Huberman, “Epatica empatia. L’affinità degli incommensurabili in Aby warburg”, in Aut-Aut, 2010, 348, Il Saggiatore, Milano 2010.
Bibliografia
- Agamben G., Signatura rerum, Bollati Boringhieri, Torino 2008.
- Didi-Huberman G, “Epatica empatia. L’affinità degli incommensurabili in Aby Warburg”, in Aut-Aut, 2010, 348, Il Saggiatore, Milano 2010.
- Galimberti U., Dizionario di Psicologia, (voce Psicologia del Profondo), UTET, Torino 1992.
- Melandri E., “I paradossi dell’infinito nell’orizzonte fenomenologico”, in Omaggio ad Husserl, Il Saggiatore, Milano 1960.
- ________ La linea e il circolo, Quodlibet, Roma 2012.
- Odifreddi P., http://www.intelligiochi.it/IG_paradossi.htm.
- Papadopoulos R., Manuale di psicologia junghiana, Moretti e Vitali, Bergamo 2009.
Scarica il PDF
- Jung, un pensiero inattuale (?) di A. Iapoce • 209 kB • 74 download