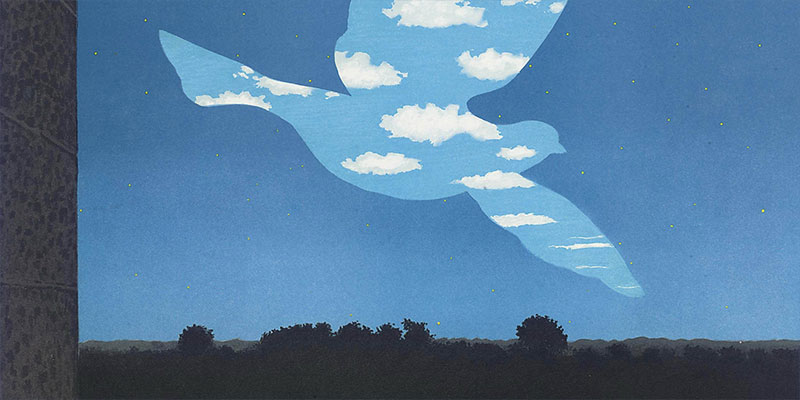
2018 Nuova Serie Numero 0 Aperture
A CURA DELLA REDAZIONE Cosa ne sarebbe della psicologia analitica, ma anche della psicoterapia più in generale, se essa si chiudesse esclusivamente all’interno della propria stanza? Se è vero che è nell’intimità sacra dello spazio di lavoro che si coagulano i processi di cura, è anche vero che solo nell’apertura all’esterno essi trovano lo spazio per respirare, esistere, radicarsi e restare vitali. In questa rubrica, lo sguardo analitico degli Autori si volgerà verso l’esterno – arte, vita, esperienze… – alla ricerca di connessioni, legami, contaminazioni, affinché il ritmo vitale del dentro/fuori, interno/esterno apra alla possibilità di una riflessione analitica sempre vivace e feconda.
Il teatrista, il buco e la salvezza
Quanto segue ha la forma sghimbescia di una scrittura in tre parti, di cui la prima, a mo’ di premessa, sopravanza di non poco le altre due: ma in questa premessa vive un’esperienza che fa da nutrimento a tutto il resto del discorso.
Le altre due parti sono:
Una breve riflessione sul tema “analisi e attore”.
E, infine, un’ancor breve conclusione ispirata al Fu Mattia Pascal.
Prima parte
La prenderò, come si usa dire, un po’ alla lontana e per questo farò appello alla vostra pazienza.
A qualcosa come quindici anni fa data il mio ritorno dalla psichiatria bergamasca a quella di Palermo.
Fu così che dall’intensissima luce al neon di quelle stanze, dal nitore dei letti di degenza e dal silenziosissimo luogo che anche lì riusciva a essere un servizio per acuti, passai, da un giorno all’altro, alla vociferante ed estraniante, per odori, suoni, colori e altro ancora, confusione di qui.
Ma a turbarmi, fino a un vero e proprio senso di sperdimento, fu l’incontro col Responsabile del Servizio della mia nuova destinazione.
Quello di prima, persona ligissima alla regola, anche lui un po’ al neon, un tutt’uno con protocolli e linee guida, ma pure persona a suo modo alla mano e disponibile nelle rogne – che del nostro lavoro, si sa, sono pane quotidiano – certo non potevo pensare che potesse reincarnarsi nella figura del mio nuovo Responsabile, qui in terra di Sicilia.
Ma, come da noi si dice: «È vero e verita!»
Il fatto era che proprio il mio nuovo capo di quella confusione sembrava essere artefice in prima persona, nonché garante istituzionale e, se il paradosso ce lo concede, custode scrupolosissimo.
Che dire dei transiti impossibili dal Pronto Soccorso senza uno straccio di carta, delle dimissioni a volte scritte su un fogliettino preso qua e là, dei turni del personale, me compreso, rabberciati di settimana in settimana, se non di giorno in giorno? E poi quelle prescrizioni all’uscita dal ricovero. Già, all’uscita dal ricovero. Era tutta una rumorosità stordente da suk della prima ora: non di rado vi si davano contrattazioni estenuanti sulle pillole da prendere a casa, sconti di dose richiesti, supplicati, implorati, in talune occasioni financo imposti dal paziente stesso e, da par suo, dal capo, ora negati, ora promessi o concessi, ma quasi sempre, comunque, sciarriati. E, quindi, via a una filiera lunghissima di ricette anche sfardate e poi riscritte, alla meglio ricopiate, con qualche svista pure; una volta, lo giuro, rimesse insieme con lo scotch!
E poi, l’inizio di giornata in reparto?
Lì, nel Bergamasco, si cominciava col calmo briefing di équipe, seduti tutti per bene e compìti, attorno a un ovale e le consegne fatte a puntino, medici, infermieri e pure gli OSA, con un linguaggio che non riusciva mai, neanche volendolo, a sgarrare di un tantino, preciso com’era, tecnicissimo, nitido come le lenzuola dei letti. E poco ci mancava, a conclusione, una dotta coda bibliografica!
Qui, all’opposto, varcato l’ingresso del reparto, veniva tutta a muoverci contro una massa chiassosa e informe di pazienti, familiari e infermieri, pure il medico della guardia notturna, uniti tutti a reclamare, lamentarsi e inveire. E lui, il Responsabile, in quel fracasso non era certo da meno, dandovi di tanto in tanto il la d’inizio, o rafforzandovi, se possibile ancor di più, con gaffes acrobatiche, certi passaggi turbolenti. Mi si faccia venia dell’azzardato neologismo: in definitiva, se ne sarebbe potuto dire come di un talentuoso direttore di disorchestra! Con l’orecchio implacabilmente attento a intercettare e colpire i (rari) momenti armonici del contesto, quasi fosse sempre pronto a incalzare: «Attenzione violino, sei troppo in sintonia col contrabbasso, e tu, pianoforte, cerca di stonare ogni tanto; tamburo, tu sei troppo concentrato nel ritmo, prova ad andare almeno un po’ per i fatti tuoi!».
E poi che dire delle riunioni sui casi? Senza stabilità alcuna di luogo, di ora e di partecipanti: ora al bar in pausa o tra una consegna e l’altra, magari al telefono in viva voce, o durante il momento di visita dei familiari, a volte nate da incroci fortuiti di corridoio, mi verrebbe da dire, qualche volta quasi per sbaglio, con chi c’è c’è. Ma potevano ancora dirsi, queste, riunioni sul caso?
Come anche il canovaccio tipo di ogni comunicazione: interruzioni continue, che a loro volta s’interrompevano simmetricamente in una spirale infinita, in cui l’ultima cosa sopraggiunta si vantava il diritto di scalzare tutte le precedenti.
Certo, di tanto in tanto, una qualche disposizione all’accomodo, da parte sua, andava pure ad ammorbidire il solito grumo di opposte tendenze; ma questa mistura era pur sempre un impasto che non faceva difetto d’invettive, di arrabbiature, di rimostranze nutrite delle altrui rimostranze, di ruffiane lusinghe e persino di perfide allusioni, non sempre, queste, colte per ciò che erano.
Insomma, il mio perturbante interlocutore del momento, medico psichiatra, poco più che quarantino, maratoneta, centauro, e gran tifoso rosanero, in quel guazzabuglio mi pareva proprio di casa, e, anzi, a dirla tutta, ai miei occhi, sembrava sguazzarci pure, a suo immenso godimento.
Poi, un giorno, lo sperdimento svaporò e prese il posto suo l’idea di aver finalmente capito, di colpo subentrando la matematica certezza di aver smascherato il personaggio in questione e con esso quel mondo che lui stesso garantiva.
E ora dirò cose di chininico sapore.
Il mio pensiero corse a Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, alla sua celebre profezia sulle Iene e sugli Sciacalletti che avrebbero un giorno preso il posto dei Leoni e dei Gattopardi (Tomasi di Lampedusa 1958).
Nel momento di quell’afosa giornata estiva, ricordo bene, la sentenza arrivò inappellabile: la Iena o lo Sciacalletto, che dir si voglia, ebbe il nome e il cognome del mio Responsabile, il dottor Enzo Cordovana.
Fu quando – entrambi in una pausa al bar – egli mi disse che a quel mestiere di psichiatra non ci credeva, ma proprio per niente. Terapia, diagnosi, prognosi, guarigione, per non parlar poi di astruserie più fini, quali comorbidità, compliance, recovery: parolone inutili e vuotissime, ai suoi occhi, e inapplicabilissime, in specie, alla sua pratica. E ora, sentite l’imperdonabile offesa arrecata al sacro Giuramento ippocratico: di sé disse di non sentirsi, di non essere e di non volerlo neppure desiderare di essere, terapeuta.
Di sé mi disse questo e questo solo: che faceva teatro, che era un teatrista.
Il fatto era che quello che poteva pure – ma a che prezzo! – passare come un personalissimo autodafè si dilatava poi, via via, nella sua smargiassa orazione, a una massima di portata generale, addirittura metafisica; e ciò si compendiava in un interrogativo da lui servitomi sul piatto intarsiato di una smorfia sfingea: come può qualcuno ardire solo di pensare di curare e persino guarire qualcun altro?
Ora non posso dire di aver visto come il mio volto si comportò alla sua smorfia, ma di poterlo immaginare, questo sì. Ecco, io il mio volto me lo vedo ancor oggi nella forma, rappresa, di un’amara piegolina a un lato delle labbra. Avvenne così che la confusione, il tutto e il contrario di tutto, lo scatafascio, la vanvera del luogo mi apparvero governati da una legge nascosta e ferrea, che dello scrupoloso primario manager lombardo si faceva un emerito baffo. Trattavasi della legge del cinico disincanto, che, ove sentenzi nel codice della morale, trasfigura nella fradicia verità del vizio ogni apparente sfavillio di virtù, e, che, ove si pronunzi nell’ordine delle cose ultime, antivede nel misero naufragio del nulla ogni anelito d’essere.
Ora, il fatto era che più il tempo passava e più il filo del ragionamento s’ingarbugliava.
Punto primo: il dottore in questione, giorno dopo giorno, si rivelava psichiatra accorto, competentissimo, di memoria di ferro quanto alla storia dei suoi malati e di raffinatissime intuizioni cliniche. E non solo questo. Pure disponibilissimo nelle varie camurrie, piccole e grandi, di ogni giorno. Mai arrogante; anzi, lui il capo, un passo indietro, sempre. Il consiglio dato che non ti fa sentire munnizza. E, ancora: persona per bene. E ancora, cristiano portato in palmo di mano.
E non solo questo: il mio capo sembrava vivere al riparo dai venti olezzosi di potere e di potericchi che non mancano di spirare in ogni luogo e che semmai imperversano ove il potere medico rischia di cicatrizzare alla meno peggio le ferite della malattia, abdicando al compito archetipico di sanarle.
Anche uomo di buone letture e di lampeggianti squarci d’intuizione, più sul versante comunque della domanda che della risposta: da quale incanto misterioso del suo animo risalì un giorno, tra una congiuntura e l’altra, quell’improvvisa sua rimembranza felliniana su cosa fosse la musica? Già, la musica: col tempo, quelle che inizialmente mi parevano le dissintonie moleste della disorchestra, cominciavano ad arrivarmi come suoni di vibrante delicatezza.
E, infine, ecco il paradosso che la prima inappellabile sentenza ribaltava, questa volta sì, senza appello alcuno: egli era terapeuta che curava e guariva; e che voleva pure bene ai suoi pazienti e da questi amato.
Insomma, le carte mi si venivano a sparigliare di nuovo, finché, a un certo punto, le chiare acque del mio giudizio di un tempo s’intorbidirono fino al punto che lo sperdimento iniziale mi ritornò e più acuto di prima.
La cosa successe all’inizio di una giornata di lavoro e la ricordo ancora, stampata bene in testa. Come dicevo, a quell’ora, una massa umana informe, e non lieve, era solita dare il suo buon giorno, e con tutti i sacramenti, al montante di turno, già dal suo ingresso in reparto. In quell’occasione, io smontavo mentre il mio capo montava.
Successe allora che il singolo dominò sui molti. L’uno avanzò e gli altri arretrarono.
Il Responsabile ci si fece innanzi con occhi sgrillati e spiritati e il suo sguardo, come un lampo, ci silenziò e ci addomesticò. Tutti ce ne ritornammo dove eravamo venuti, mogi e zitti: pazienti, familiari, infermieri, ausiliari, e io in mezzo agli altri, e manco azzardammo a chiedergli una cosuzza da niente. C’era poi a scombussolarci non poco il fatto che quel giorno il nostro aveva violato le sacre ferie.
Quando poi si fece un pochino più calmo, egli questo ci raccontò, stretto e asciutto.
Quella mattina, prestissimo, che forse continuava a essere notte, si era svegliato angosciatissimo, ancor dentro testa e corpo nell’incubo da cui veniva. Aveva sognato che Peppino, quel secchissimo spilungone, alto sopra i due metri, che nella realtà lui aveva dimesso tre giorni prima – e Dio solo sa, anche in quel caso, quale turbolento parapiglio si era dato ai nostri occhi – quello spilungone, dicevo, pallidissimo e ancora malatissimo, non si sa come e per quale ghiribizzo della testa, era riuscito a passare attraverso la strettissima presa d’aria del finestrone della stanza di degenza. E ora, Peppino da lì pendolava, tutto aggrappato al sottilissimo davanzale che dava su un vuoto di dieci metri buoni e lo chiamava, lo invocava, gli gridava di venire a prenderlo, di venire a salvarlo.
Così il sogno di Vincenzo Cordovana.
Risvegliatosi di soprassalto, non ci aveva più dormito e il letto gli era venuto a tormento:
«Mi votu e mi rivotu suspirannu, ma senza biddizzi a contemplari», proprio come smorfiavamo la struggente canzone di Rosa Balistreri[2] per sfruculiare il sonno latitante dei nostri pazienti.
Il pensiero di Peppino non lo aveva lasciato più, gli aveva tolto il sonno e lo aveva fatto precipitare, ad onta della sua apparente natura loffia, dritto dritto al Pronto Soccorso, sebbene quel giorno fosse di riposo, e lì aveva trovato Peppino: angosciatissimo, cereo se possibile ancor più del suo solito, ma per nulla sorpreso di vedervi scoppare il suo medico. Qualche ora prima, in preda a un furore che non sapeva di che pasta avariata era, Peppino, facendo pendant col suo brutto sogno, si era scaraventato di brutto contro il finestrone della sua stanza per buttarvisi di sotto e farla così finita col suo calvario, quand’ecco che gli era venuto in testa il suo medico e che questi lo avrebbe salvato da quella canazza tinta che era la sua malattia: anzi, tirando fuori tutto l’urlo della bestia ferita, aveva invocato il Cordovana di venire subito a pigliarlo. Dal frustulo di sollievo che ne aveva avuto, si era così deciso ad andare con i suoi piedi al Pronto Soccorso, ché il suo medico Peppino era sicuro di trovarlo lì ad aspettarlo.
Fine del racconto.
Nessun commento, nessuna parola e simili. Men che meno un bisbiglio infame d’interpretazione.
Di quanto era successo, nell’anno e mezzo che io fui ancora in quel reparto non si parlò mai, né, incontrandoci fuori da lì, un accenno di discorso vi fu preso. E neppure, penso, per ritrosia, pudore o altro sentimento meritevole di silenzio. Forse, semplicemente, non se ne cercò più il filo perché non ci si pensò più.
Punto.
Qui finisce l’ampia divagazione per cui ho fatto appello alla vostra benevola pazienza e vengo al tema.
Eppure, mi prenderò ancora due ultime parole su questa storia.
Quello psichiatra, che diceva di non sapere, né di volere curare e guarire e che invece curava e guariva pure, quel giorno aveva però operato nell’ordine della salvezza; ordine, questo, che va però di gran lunga ben oltre quello della cura e della guarigione.
Ora, quando dico salvezza, lo faccio con una parola che voglio qui profferire nel senso più laico possibile del termine; eppure, se qualcuno vorrà recepirla con una qual certa intonazione religiosa, sappia che non me la prenderò comunque a male e che, anzi, sarei disposto pure a fargliene una liberatoria apposta.
Il mio discorso si ricongiunge adesso alla mia riflessione su Pirandello, nell’affermare che,
se salvezza quella volta ci fu, ci fu proprio perché il mio capo pensava di fare teatro e di essere un teatrista.
Ora proverò a spiegare perché.
Parte seconda
Sulle consonanze tra analisi e teatro, lo sappiamo bene, c’è di certo un gran bel dire nella letteratura analitica e non starò qui a farne un sunto che abbia pretese di completezza. Mi limiterò solo a essere debitore di ciò che Augusto Romano[3] ha mirabilmente scritto al riguardo, nel paragonare il terapeuta a un attore, giustificando l’accostamento in virtù del fatto che entrambi incarnano continuamente figure sempre diverse; avendo peraltro, ciascuno a suo modo, la funzione di spingere l’altro alla commozione.
Romano tratteggia due esemplari drammaturgie assai diverse tra loro, l’una enunciata da Denis Diderot (1830), l’altra da Konstantin Stanislavskij (1938).
Cominciamo dal secondo. Questa tipologia, che di certo lusinga di più il nostro amor proprio di analisti, avrebbe a che fare, infatti, almeno nelle intenzioni, nientemeno che con la verità. Vissuto e verità vi si unirebbero insieme, avendo così luogo una grandiosità che si traveste di autenticità. Stanislavskij chiede infatti all’attore di essere fino in fondo il personaggio che interpreta, giacché il solo apparire non basta proprio, occorre essere.
Se la parola è il risultato di un processo, l’attore deve fare questo processo per proprio conto, risalire dalle parole ai pensieri e ai sentimenti che le hanno originate: rifare quindi, da un punto di vista organico, il periplo dell’autore. E perciò l’attore deve ricostruire il ‘sottotesto’, ritrovare al di là delle parole il vissuto. A tal fine, egli dovrà ricostruire la vita del personaggio, riempire i vuoti lasciati nel testo dall’autore, innestare sulla linea biografica del personaggio sue esperienze analoghe che renderanno vissuta quella biografia (Romano, p. 8).
Come non sfuggire alle Sirene che con Stanislavskij ci cantano il sacro peana dell’Autenticità, dell’Immedesimazione e dell’Empatia? Parola, questa, che avrebbe peraltro trovato un’ulteriore glorificazione da recenti studi sul cervello e sul comportamento scimmieschi. Si tratta, in fondo, di quella sorta di postulato ontologico-metafisico che può andare sotto il nome di Relazione, nelle sue diverse declinazioni di intersoggettività, di spazio interpersonale, e via dicendo. Ora, non che si voglia ritornare all’asettica parola kraepeliniana, ma come non ammettere che il termine Relazione sia a volte svilito al ruolo di melensa parola d’ordine, passe-partout per ogni buon percorso terapeutico, per cui saggio, forse, potrebbe essere il proporne una durevole moratoria d’uso?
Ma ad aggravare il quadro è poi quanto Romano ci dice sul possibile sentimento di onnipotenza che si annida nel programma eroico della tentazione Stanislavskij: «l’ambiguo piacere di sentirsi buoni, e ancora il gusto del tormento interiore e della ruminazione che sono a volta la droga dell’analista, il suo vizio professionale» (ibidem).
E che, diremmo noi, sono forse la più insidiosa spinta mortifera con cui l’analista può colludere rispetto alle aree di morte del paziente.
Mentre, prosegue Augusto Romano:
… non è possibile trattare ogni genere di pazienti, giacché l’empatia e l’analogia delle esperienze hanno un limite […] e, nell’ottica di Stanislavskij, [l’analista] non può fare a suo piacimento Amleto e Falstaff. […] Ognuno dovrebbe rispettare il suo limite (ibidem).
Altro è invece quanto ci suggerisce Diderot ne Il Paradosso sull’attore.
Qui la testa sembrerebbe averla vinta sul cuore e il lucido discernimento verrebbe a prevalere sulla calda sensibilità:
Il suo [dell’attore] talento consiste non nel sentire […] ma nel rendere i segni esteriori del sentimento con tanta scrupolosità che voi [spettatore] ne restiate ingannato. Egli non è il personaggio, lo interpreta, e lo interpreta così bene che voi lo scambiate per quello (ivi, p. 7).
Tutto deve essere calcolato, combinato, ordinato nella sua testa. Così continua Romano, citando Diderot:
Le lacrime dell’attore […] scendono dal suo cervello. […] Il vero talento consiste nel conoscere a fondo le manifestazioni di quest’anima presa a prestito (ibidem).
Egli non è mai il suo personaggio, ma lo interpreta, e su ciò vale proprio la pena soffermarsi, per cogliervi una paradossalità feconda di presenza-assenza, di pieno-vuoto, di qui-altrove, per cui il teatro, ci suggerisce Antonin Artaud: «ristabilisce il legame tra ciò che è e ciò che non è, tra la virtualità del possibile e ciò che esiste nella natura materializzata» (Artaud 1938,123). Ma di cosa ciò ci parla se non della magia archetipica della maschera[4] e della sua fiera rivincita sulla folgorante immagine dell’eroe?
È chiaro, peraltro, che la mozione-Diderot non vada molto a genio a noi analisti, laddove tornerebbe più remunerativo fare del sentimento la linfa vitale del nostro lavoro; mentre qui il sentimento sembrerebbe mancare del tutto.
Ma, a ben vedere – ci avverte Romano – forse non è proprio così, nel senso che anche nel modello Diderot il sentimento gioca la sua parte, «solo che non è volto direttamente all’esterno, ma piuttosto tutto concentrato sul compito. Da questo punto di vista – osserva Romano – il modello di Diderot tocca una sorta di ascetismo» (ibidem).
Se questa particolare tipologia riesce a non scivolare nella versione degradata dell’analista demiurgo che pensa di poter incarnare tutte le parti, può invece venircene quella dell’attore- analista che si mette al servizio del suo personaggio con la discreta devozione dell’artigiano scrupoloso.
Dice l’autore (ibidem): «L’analista, per così dire, si svuota di sé ma al tempo stesso non si concede di essere invasato, cioè insieme illuminato e accecato», aggiungendo – e qui la cosa sembrerebbe perfettamente addirsi alla sincronicità onirica occorsa al mio Responsabile – aggiungendo, dunque, «Questo, se mai accadrà, appartiene all’ordine del miracolo, e non può essere cercato; anzi, va contrastato sino al momento in cui non ci si debba dichiarare vinti» (ibidem).
In effetti, il mio Responsabile non fece niente perché quell’esperienza gli accadesse e su questo niente vi prego di porvi la massima attenzione, perché credo ci sia il succo del mio discorso. Anzi, si potrebbe dire che tutta la sua pratica quotidiana sembrava rifuggire da ogni esplicita e programmatica intenzionalità terapeutica; certo egli, se si può dire, sé nolente, finiva comunque per curare; e del resto, l’atto prescrittivo stesso anche di una pilloletta non può non ricadere nell’orbita della cura. Ma egli era ben consapevole dello scarto posto tra sé e il terapeuta e questo scarto era forse proprio il suo essere, sono le sue parole, teatrista, e che all’inizio della storia, non di rado, mi diede il suo bel tormento: ma questo c’è o ci fa? Ora, io penso proprio che questo nulla, questo scarto irriducibile sia lo spazio propizio germinativo del primo dei tre Verbi, il Gehen-lassen, il lasciare accadere, di cui ci dice Jung; dove «l’Io che ritiene di occupare tutto il mondo pensabile, deve limitarsi, ridursi, contrarsi, per lasciar spazio alle emanazioni dell’inconscio» (Romano, ibidem), così ricambiandogli, ci verrebbe da dire con un sorriso, la cortesia iniziale, quando, in origine, fu invece l’inconscio a limitarsi per consentire all’Io di costituirsi.
Mi sovvengono adesso due metafore, entrambe avendo a che fare con la luce.
Al modello Stanislawskij sembrerebbe ben addirsi quella dell’intenso fascio di luce che, prepotente, prova a chiarire fino in fondo il dato d’esperienza che ha di fronte, con l’ambizione di creare le premesse di una sua fedele riproduzione.
Questo fascio potrebbe essere rappresentato dalla figura del faro, con le sue seducenti blandizie, specie quelle che operano a partire dalla sua odierna versione, quella del sottilissimo raggio laser di precisione. Ai nostri giorni, infatti, circola sempre più nei congressi di Medicina, come pure in quelli di Psichiatria, un nuovissimo conio idiomatico, che è per l’appunto quello di Medicina di Precisione[5]. Si dà così nome al tentativo d’individuare, attraverso una sofisticata indagine genetica combinata con un’infinita raccolta di dati clinici, il luogo esatto del tarlo da cui il morbo ha avuto origine e di confezionarvi un miratissimo antidoto[6]. Qui, s’impone però la considerazione che se anche il mondo Psi- pretende d’essere anch’esso di precisione, esso può così di misconoscere la rotondità irriducibile dell’esperienza della vita che ha davanti; il cui battito, ci dice Emanuele Trevi (2017) riprendendo Clarice Lispector, è «insieme un ritmo e un’aritmia»: il profondo dell’esistenza che, secondo la scrittrice brasiliana, «emerge per bagnare e cancellare le tracce del pensiero».
È così lecito ipotizzare che ove la cura della psiche venga ingenuamente a impigliarsi nel dogma della precisione puntiforme, essa rischia al tempo stesso di perdere di vista l’intero, depauperandosi della sua originaria vis sanatrice e uniformando il suo oggetto a cosa piatta e inerte.
Ritornando all’analisi, ci si può ragionevolmente chiedere quanto l’istanza d’onnipotenza, che acceca proprio con la sua luce, si estenda al terapeuta Stanislawskj: il fascio di luce che con la sua potenza annulla le sfumature chiaroscurali di cui si sostanzia la vita[7].
Altro, invece, sembrerebbe essere il terapeuta à la Diderot, col suo nulla appresso, umile artigiano dello scarto, a cui potrebbe addirsi piuttosto quel felice ossimoro con cui Maria Ilena Marozza (2012) prova a definire l’analista, come esperto di niente. E alla cui figura, con un po’ d’astuzia, come vedremo, provo piuttosto ad accostare l’immagine di un’altra fonte di luce, quella del Lanternino.
E con ciò andiamo finalmente al Fu Mattia Pascal (Pirandello 1904).
Parte terza
Prima di entrare nel merito, qualcosa soltanto accenneremo però alla questione della forma, che, lo sappiamo bene, è già sostanza.
Non sembra Mattia Pascal, in effetti, nutrire alcun interesse per lo stile del proprio racconto; sollecitato infatti dallo stesso don Eligio a rifarsi a modelli letterari per via del «loro particolar sapore» (ivi, p.8), egli così dice: «io scrollo le spalle e gli rispondo che non è fatica per me» (ibidem); così calando sul tavolo l’Asso di Briscola che parrebbe chiudere la partita di questa singolare poetica: il fu Mattia si rivela assai poco incline a fare seguire ai propri propositi e convincimenti fatti che siano con essi in rapporto di coerenza: egli si fa narratore, che scrive per distrazione.
Ma tutto ciò, pur con le dovute differenze del caso, non è in qualche modo in sintonia con lo stile di quel terapeuta che curava anche lui, se così si può dire, per distrazione, o con l’esperto di niente, di cui ci diceva prima Maria Ilena Marozza?
Vado, dunque, dritto ai capitoli dodici e tredici del Fu Mattia, alla cui lettura, in particolare, m’ispiro per la mia conclusione.
Ma prima di provare a ragionarci un po’ intorno, vorrei dirvi la prima cosa che mi è venuta in mente.
Che strana tenerezza ci può essere nel pensare che venga a riferirsi pure a noi, alla nostra vita associativa di analisti e ai nostri incontri, a volte tutto un contorcersi di oblique allusioni, di dispute aspre e di acidi malintesi, ma anche di salamelecchi e ruffianerie, incontri ove di tanto in tanto vien pure a farci visita la grazia dell’incontro, che venga a riferirsi pure a noi, dicevo dunque, quello che Anselmo Paleari così descrive:
… scompiglio delle singole lanternine: chi va di qua, chi di là, chi torna indietro, chi si raggira; nessuna trova più la via; si urtano, s’aggregano per un momento in dieci, in venti; ma non possono mettersi d’accordo, e tornano a sparpagliarsi in gran confusione, in furia angosciosa: come le formiche che non trovino più la bocca del formicajo, otturata per ispasso da un bambino crudele (ivi, p. 184).
Andiamo avanti, dunque.
Nel capitolo dodici de Il fu Mattia Pascal, L’occhio e il Papiano (ivi, p. 132), Anselmo Paleari ci introduce alla filosofia del buco nel cielo di carta: l’incidente casuale e banale che disvela l’effimera convenzionalità del nostro stare al mondo e che ci toglie il terreno da sotto i piedi.
Potremmo leggervi l’ombra dell’Unheimliche? A ben vedere, sì: e, dunque, la pubblicazione de Il fu Mattia gioca di buon anticipo, quindici anni, su quella de Il Perturbante (Das Unheimliche,1919) di Sigmund Freud e di appena due la prima introduzione del concetto in questione in ambito psicologico con Ernst Jentsch, che è del 1906[8].
Per quel che ci riguarda come junghiani, non si fa certo fatica ad apparentare all’immagine del buco nel cielo di carta l’irruzione dell’inconscio nel pacato flusso coscienziale; e con esso, lo sfrangiamento egoico, che non è solo, lo sappiamo bene, sinonimo di malattia, ma anche, quando ci va bene, sinonimo di preziosa chanche individuativa.
Ora, a pensarci bene, quei giorni di lavoro qui in terra di Sicilia erano tutti un irrompere di strappi e di scucitezze e quell’apparente trascuratezza della prassi quotidiana ne era una sorta di pacifico salvacondotto, recante a suo modo il marchio di fabbrica del cielo di carta.
Nel nostro gergo potremmo forse dire che il gioco dell’Io vi si svolgeva al ribasso: non penso che si trattasse di una intenzionale disintenzionalità: nulla di programmatico di certo, le cose andavano così, per conto loro, e, a dire il vero, non saprei darmene una spiegazione su come la cosa si mise a funzionare in tal modo; sta di fatto che quel parapiglio alla fine funzionava, in termini, mi perdonerà il Cordovana, anche di recovery, compliance e abbattimento dei drop out; e, direi a occhio, forse persino meglio rispetto ai luoghi bergamaschi. E magari, capitava di divertirsi pure, come quella volta che il casino giocoso tra medici e pazienti assunse tali acuzie sonore che gli infermieri si precipitarono scantatizzi. A proposito ricordo: una volta dissi a un mio collega analista più anziano del dono che il nostro lavoro a volte ci fa nel concederci la gioia del divertimento, e lui mi corresse, “dottore, non divertimento, ma passione” e io a ribattere presuntuosetto, “no dottore, non solo passione, ma anche divertimento”.
Nella stanza d’analisi quel buco, sappiamo bene, coincide col vero inizio dell’analisi stessa. Su questo Fédida dice magistralmente:
L’analista non può che attendere una cosa: l’inquietante estraneità, il perturbante. Se si trova all’interno di una familiarità del simile, si trova all’interno di una pratica della teoria dell’Io, teoria che fa sì che io sia supposto aiutare l’altro perché immagino di potergli somigliare […] Il processo analitico umano-disumano comincia con l’inquietante estraneità, che è ciò con cui l’analista ha un appuntamento. Se questo incontro non c’è, non vi è nessuna possibilità di pensare di poter curare un simile. ‘Inquietante estraneità’ significa che è lì dove qualcosa s’infrange, si interrompe, che ci si può mettere ad ascoltare, ad intendere (Fédida 2007, p.82).
Discorso che sembra nutrirsi del celebre passo platonico del Cratilo (Platone 414. B):
Ma tu non ti rendi conto che io mi lascio trascinare fuori dal seminato non appena imbocco un tratto liscio?
Ora, tuttavia, non vorrei far torto a Fédida e al suo possibile antico mentore greco
nell’affermare che il buco tuttavia un cielo di carta lo presuppone inevitabilmente.
Checché ne pensi certa deriva New Age del discorso junghiano, e non solo di questo, la teoria rimane, infatti, premessa irrinunciabile per una sufficientemente buona prassi terapeutica; e ciò non solo come momento di necessario ancoraggio ordinativo, rispetto alla possibile invasione unheimlich connessa all’impatto con la sofferenza psichica. E, tuttavia, il buon uso della teoria esige, Jung ce lo insegna e le parole di Marozza ce lo ribadiscono a chiare lettere, che questa sia «smentita nell’autentica esperienza terapeutica, per costituire lo sfondo sul quale emerge, per contrasto, il caso individuale» (Marozza 1999, p. 30).
Se ne potrebbe dire di un sapere che, nella sua crescita, costella generative lacune di mancanza, la cui bellezza è forse quella che ci arriva dai versi di Sandro Penna:
La bellezza di quelli che non sanno/Non è più bella di quelli che sanno?
Detta smentita non è forse il buco nel cielo di carta della stanza d’analisi?
La teoria, forse, come male necessario? Chissà!
Ciò detto, dunque, può servirci per fissare qualche paletto al nostro percorso: come dire, restando al capitolo dodici, va bene Amleto, ma anche Oreste ha le sue ragioni: possiamo tentare di mettere i due in una feconda, per quanto complicatissima, tenzone dialogica?
E, ora, due parole conclusive, a partire dal capitolo tredici, Lanterninosofia (Pirandello 1904, p. 182).
Qui, è mio parere, incontriamo una delle chiavi di volta del discorso pirandelliano. Mi riferisco al tema del Nulla. E lo farò solo per un brevissimo cenno, e gli interrogativi, vi dirò subito, sopravanzano le risposte.
Intanto, non ci sfugga la dolentissima circostanza dell’incontro tra Meis e Paleari: la prigionia cieca dell’esistenza da cui muove il bisogno del conforto cresciuto fino all’esasperazione.
Da qui, la prima domanda: non è forse questo il luogo d’origine dell’Arte? Ma la stessa condizione non è anch’essa linfa del lavoro analitico?
Del nulla, dunque, vi si dice in questo passo; ma possiamo parlare di nichilismo? qualche dubbio me lo fa venire la domanda pirandelliana, che così ci interpella:
Spento alla fine a un soffio, ci accoglierà la notte perpetua dopo il fumoso giorno della nostra illusione, o non rimmarremo noi piuttosto alla mercé dell’Essere, che avrà soltanto rotto le vane forme della nostra ragione? (ivi, p. 183).
Sì: qui di Essere si dice anche; e con la maiuscola. La questione può dunque dirsi lasciata aperta?
Ma la domanda che qui mi pare più opportuna, toccandoci direttamente, è un’altra: In quale zona si adagia il nostro fare analitico?
Nel cerchio più o meno ampio di luce – di qualsivoglia intensità e colore che sia – del lanternino o nell’oscurità che lo circonda da ogni parte?
Ecco, io vi proporrei questo.
Si potrebbe immaginare un filo molto tenue, un impalpabile limen, che la luce separa dal buio – anzi, si può dir meglio – un limen che è ancora luce e ancora buio, luogo delle verità intraviste e che subito si sottraggono allo sguardo. Chiamo qui a testimoniare una marionetta; e mi riferisco alla toccante interpretazione che Totò fa di Jago nel film Cosa sono le Nuvole (1968)[9], a regia di Pasolini, in particolare alla scena in cui alla domanda su cosa sia la verità, egli così risponde:
JAGO: Cosa senti dentro? Concentrati bene. Cosa senti?
OTELLO: Sì, sì, si sente qualcosa che c’è!
JAGO. Quella è la verità. Ma, ssh! Non bisogna nominarla, perché appena la nomini, non c’è più. Mi sovviene la tesi kabbalistica della creazione del mondo che procede dal ritiro di Dio.
Se ne potrebbe dire come del momento in cui l’Essere si ritrae per dar modo anche al nulla di aver la sua parte.
È a partire da questa esigua frangia chiaroscurale che al mio collega e a Peppino fu data la grazia di quell’incontro? E questa grazia, se ci fu, non si diede forse nell’ordine di quel miracolo che, come ci dice Romano, «non può essere cercato; e che, anzi, va contrastato sino al momento in cui non ci si debba dichiarare vinti»?
Per questo, mi piace pensare che se un nume tutelare avrà mai protetto il mio Responsabile, non sarà stato il Dio onnipotente, il Pantocrator della nostra splendida Cappella Palatina, colui che tutto tiene, ma colui di cui ci parla Emmanuel Lévinas alla fine di Nuove Letture Talmudiche:
Iniziativa del concedere che, nello scontro di forze cieche, nella disputa che è forse il senso – o il non senso – del caos che precede l’essere, rende il mondo possibile. Essere come pace, e fondato sul movimento apparentemente negativo del ritegno. Ontologia aperta alla responsabilità verso gli altri. (Lévinas 1996, p. 97)
Note
- [1] Psichiatra, analista del CIPA.
- [2] Mi votu e mi rivotu suspirannu/passu li notti ‘nteri senza sonnu/E li biddizzi tò iu cuntimplannu/li passu di la notti ‘nsinu a jornu. Il canto Mi votu e mi rivotu è la canzone più ascoltata del repertorio di Rosa Balistreri. È molto antica, e l’autore, come in quasi tutti i canti popolari, è sconosciuto. Rosa Balistreri afferma di aver sentito cantare questa canzone per la prima volta dentro il carcere di Palermo, ed ha attribuito ad un carcerato la composizione; in realtà il testo di questa canzone è presente nella raccolta di Canzoni siciliani del Frontini.
- [3] Relazione tenuta il 21 maggio 2006 in occasione del Convegno La comprensione dell’altro organizzato in Firenze dalla rivista Anima, consultabile on line nel sito www.arpajung.it, dal titolo Limiti della comprensione.
- [4] Per una ricca ricognizione sugli aspetti antropologici e psicologici della maschera, si rimanda al saggio di Angiola Iapoce, Psiche: una maschera necessaria, in Inganno e autoinganno (M. Failla a cura di), Fattore Umano Edizioni, Roma 2017, pp. 202-203; ove, in particolare, se ne sottolinea la valenza «di elemento di transizione tra sé e il mondo, un luogo esemplare dell’intermediarietà […], il transito per rendere visibile l’invisibile e l’incomunicabile, cioè non il corpo anatomico, ma il corpo ‘emotivo’, il corpo affettivizzato, il leib». In tal senso, seguendo il pensiero dell’Autrice, potremmo dire che la rivincita che la Maschera si prende sull’Eroe è quella del dispositivo dell’eccedenza trasformativa sul dispositivo, in sé concluso, dell’onnipotenza autoreferenziale.
- [5] Che sembra fare il paio con l’altro irrinunciabile conio idiomatico di Evidence-based Medicine (EBM). Sul rischio di una semplicistica estensione dell’EBM dalla Medicina alla Psichiatria si veda l’illuminante posizione critica contenuta nell’articolo di Susanna Every-Palmer e di Jeremy Howick (Journal of Evaluation in Clinical Pratice, 2014).
- [6] Per la cronaca: Obama vi ha stanziato un investimento iniziale di 200 milioni di dollari. Il primo risultato entrato nella pratica con questa funzione è stato per esempio l’anticorpo monoclonale trastuzumab, approvato negli Stati Uniti nel 1998, per trattare i tumori del seno che esprimono sulle cellule il recettore HER2.
- [7] Nella Prefazione di Filippo Maria Ferro alla recentissima edizione italiana del testo del 1906 di Eugen Bleuler, trad. Affettività, Suggestione, Paranoia, (Fattore Umano Edizioni, Roma 2017), a pagina XII si fa riferimento a «… una psicopatologia che alla moda delle evidenze sacrifica le sfumature che pure dovrebbero costituire l’essenza del suo ‘speciale’ sapere».
- [8] Freud, in effetti, si rifà alla teorizzazione di Jentsch, secondo cui la modalità drammaturgico/retorica presente in alcune opere letterarie si fonda essenzialmente sull’escamotage di porre il lettore di fronte a una sorta di paradosso cognitivo, nel quale egli si trova impossibilitato a decidere se alcuni personaggi della storia siano oggetti animati o inanimati, esseri viventi oppure cose senza vita. Vi si può agevolmente rinvenire una sorprendente analogia col capitolo de Il fu Mattia in questione, a proposito delle pirandelliane marionette rimaste attonite all’avvenuto buco.
- [9] Cosa sono le nuvole, Regia di Pier Paolo Pasolini, episodio del Film Capriccio all’italiana, 1968.
Bibliografia
- Artaud A. 1938, trad. Il teatro e il suo doppio, Einaudi, Torino 1968.
- Diderot D. 1830, trad. Il paradosso dell’attore (a cura di R. Serpa), Angelo Signorelli, Verona 1993.
- Every-Palmer S. e di Jeremy Howick J., Journal of Evaluation in Clinical Pratice, 2014. Fédida P. 2007, trad. Umano/Disumano, Borla, Roma 2009.
- Ferro F.M. 2017, Prefazione a Eugen Bleuler, Affettività, Suggestione, Paranoia, Fattore Umano Edizioni, Roma.
- Iapoce A. 2017, Psiche: una maschera necessaria, in Inganno e autoinganno (a cura di M. Failla), Fattore Umano Edizioni, Roma.
- Jentsch E. 1906, Zur Psychologie des Unheimlichen, Kessinger Publising, Whitefish USA 2010.
- Lévinas E., 1996, trad. Nuove letture talmudiche, SE, Milano 2004. Marozza M 2012, Jung dopo Jung, Moretti&Vitali, Bergamo.
- Marozza M. 1999, La clinica come problema epistemologico, in Psicologia Analitica. La teoria della clinica (a cura di L. Aversa), Bollati Boringhieri, Torino.
- Pirandello L. 1904, Il fu Mattia Pascal, Einaudi, Torino 2014.
- Platone 1997, Cratilo. Tutte le opere (a cura di E.V. Maltese), Newton Compton, Roma.
- Romano A., Limiti della comprensione, www.arpajung.it., pp. 1-10. Stanilaslvskij K., 1938, trad. Il lavoro dell’attore su stesso, Laterza 2008. Tomasi G. di Lampedusa 1958, Il Gattopardo, Feltrinelli, Milano 1963.
- Trevi E. 2017, in La Lettura, Supplemento al Corriere della Sera del 26 marzo 2017.
Scarica il PDF
- Il teatrista, il buco e la salvezza – Francesco Di Nuovo • 220 kB • 108 download
