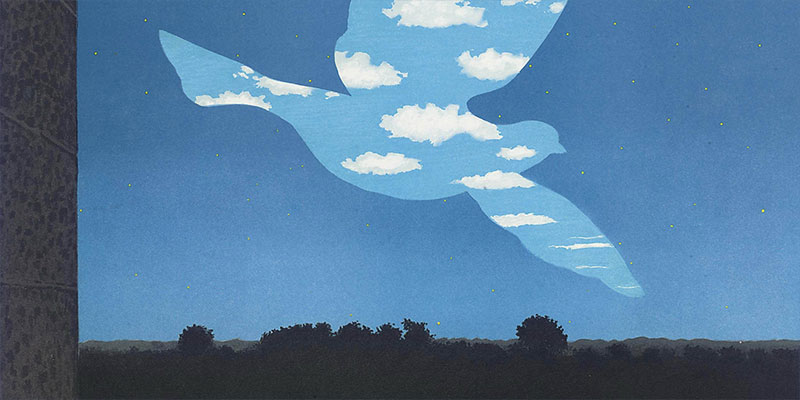
2018 Nuova Serie Numero 0 Aperture
A CURA DELLA REDAZIONE Cosa ne sarebbe della psicologia analitica, ma anche della psicoterapia più in generale, se essa si chiudesse esclusivamente all’interno della propria stanza? Se è vero che è nell’intimità sacra dello spazio di lavoro che si coagulano i processi di cura, è anche vero che solo nell’apertura all’esterno essi trovano lo spazio per respirare, esistere, radicarsi e restare vitali. In questa rubrica, lo sguardo analitico degli Autori si volgerà verso l’esterno – arte, vita, esperienze… – alla ricerca di connessioni, legami, contaminazioni, affinché il ritmo vitale del dentro/fuori, interno/esterno apra alla possibilità di una riflessione analitica sempre vivace e feconda.
Pirandello ridens
Luigi Pirandello, come tutti i più grandi scrittori, sapeva osservare e descrivere, con grandissima precisione, la nostra condizione umana in tutte le sue sfumature. Ciò che, con un’insolita perspicacia, Pirandello coglie della nostra realtà umana sono proprio le nostre incongruenze e le nostre contraddizioni. Non esprime né approvazione né condanna nei confronti di chi cade nel tranello delle contraddizioni; non si pronuncia né a favore né contro le decisioni prese dai suoi personaggi, e non giudica. Pirandello si limita a cogliere e a mettere in evidenza questo inevitabile fenomeno di vita.
In questo Pirandello è in perfetta sintonia con Carl Gustav Jung che, a sua volta, sottolinea l’importanza delle inevitabili contraddizioni della vita (Jung 1934/1939, pp. 20, 118). Anche in quei momenti in cui crediamo e sentiamo di essere veramente convinti di un principio, della correttezza di un gesto o di un passo da fare nei confronti di qualche problema, se ci ascoltiamo con grande attenzione, sentiremo da qualche parte dentro di noi – insegna Jung – un’altra voce. Come Pirandello, anche Jung mette in discussione l’illusione della compattezza e della solidità della personalità. C’è – ci insegna Jung – una fondamentale dissociabilità nella personalità che tende a dividersi, a volte persino a frammentarsi, davanti a certi stimoli. Siamo fatti così, dice Jung. Ci piace credere che le nostre personalità siano dotate di un altissimo livello di coesione interna, ma spesso non possiamo negare che la realtà è un’altra. Questa dissociabilità non andrebbe vista come un difetto, perlomeno non sempre (Jung 2006, vol. I, p. 397). Essa, infatti, è ciò che rende la personalità un vero sistema, una rete, un network in cui le diverse parti interagiscono tra di loro e a volte si scontrano. La tensione tra gli opposti dentro l’essere umano diventerà per Jung la base della sua visione dell’energetica psichica. La tensione tra gli opposti diventerà per Jung quel luogo (interno ma anche esterno) in cui un individuo si definisce (o non si definisce) come persona etica. Arriva, il nostro Jung, a vedere e a interpretare l’immagine del Cristo crocifisso come rappresentazione dell’esperienza umana per eccellenza: la tensione tra gli opposti retta e vissuta lealmente fino in fondo (Jung 2006, vol. II, p. 414).
Tornando a Pirandello, le vicende di Moscarda, nel romanzo Uno, nessuno e centomila illustrano benissimo la dissociabilità della personalità. Lo stimolo altro non è che un commento, apparentemente insignificante, della moglie sul fatto che il naso del protagonista sia storto. Ma questo innocuo commento funge da solvente, e quel collante che tiene insieme i pezzi della personalità, donandoci un senso di identità, si scioglie.
Lo strumento che Pirandello utilizza per trattare l’incongruo nell’esistenza umana è, in gran parte, l’umorismo. Nel suo saggio dedicato proprio al tema dell’umorismo – pubblicato per la prima volta nel 1908 – Pirandello esamina come tanti altri scrittori del mondo classico e della scena contemporanea abbiano utilizzato l’umorismo e fa delle distinzioni preziose tra ciò che è semplicemente comico, l’ironia e, infine, l’umorismo. Il comico separa, mette distanza, ridicolizza e suscita una risata liberatoria in cui, chi ha dato vita al momento comico (la vittima del comico), altro non è che lo sfortunato oggetto da cui, noi che ridiamo, ci allontaniamo. Esso assomiglia per certi versi alla funzione ‘attiva’ della proiezione che divide. L’ironia, invece, rischia di degenerare e diventare sarcasmo. Dal canto suo, Pirandello nei suoi scritti osserva e descrive senza mai dimenticare che del momento comico siamo tutti osservatori ma anche protagonisti (o vittime, se volete). Ridiamo del serioso avvocato oppresso dall’afa della vita, che si chiude in una stanza col suo cagnolino nella novella La carriola (Pirandello 2007, vol. V, p. 214), o del povero Belluca, il contabile docile e preciso che esce dall’oppressione della sua vita grazie al suono del fischio del treno che ha udito (o che crede di aver udito) (ivi, p. 79). Ridiamo dell’illustre professore Bernardino Lamis (Pirandello 1954,1012) che presenta la sua lectio magistralis sul manicheismo davanti a un’aula affollata… di soprabiti, ma non di studenti! Ridiamo di loro, ma anche di noi stessi perché Pirandello – e in questo risiede un aspetto importante del suo genio ma, soprattutto, della sua umanità – condisce il comico e l’ironia con un grande senso di partecipazione e di compassione, forze che uniscono, non separano. L’operazione di Pirandello ci porta vicini a ciò che Jung definiva ‘proiezione passiva’ – quel gesto di empatia che ci spinge ad attribuire ad un’altra persona le nostre reazioni emotive e di provare ciò che prova l’altro (o che crediamo provi l’altro) (Von Franz 2010, pp. 17-26). Proviamo imbarazzo per uno che è in imbarazzo, la vergogna di un amico è anche la nostra vergogna, e condividiamo e partecipiamo alla gioia di un nostro vicino. Come scrive Peter Berger, sociologo e autore di un interessantissimo libro dal titolo Homo Ridens (1999), l’uomo è il proiettore nella vita perché lui in primis è proiettato (ivi, p. 305). Ognuno di questi personaggi pirandelliani è una sorta di everyman: siamo tutti noi. E in questo traspare un tema importante della psicologia di Jung, il tema dell’Anthropos che per Jung è l’archetipo della nostra comune, condivisa umanità (Von Franz 1994, p. 133). Siamo tutti, in ultima analisi, nella stessa barca.
Nella sua arte Pirandello fa ciò che Jung ci incoraggia a fare nei confronti della nostra sofferenza, ma anche in quei momenti in cui ci sentiamo (o forse in cui siamo realmente) ridicoli: vivere l’esperienza pienamente, ma allo stesso tempo osservare noi stessi mentre la viviamo. Nei suoi seminari sulle ‘visioni’ di una paziente americana, Jung illustra come a volte dobbiamo ‘chiudere l’Anima in una provetta’ e osservarla senza permettere che essa produca nessun agito nella vita (Jung 1930-1934, vol. I p. 613). In un altro testo, Jung usa l’immagine di un uomo che si trova in una vallata dove si scatena un temporale (1988, p. 285). L’uomo si bagna, patisce il freddo, soffre, ma idealmente una parte di quello stesso uomo si trova in cima ad un’alta montagna, al di sopra del temporale e delle nuvole, e da lì osserva ciò che gli sta succedendo e ciò che sta provando. Ma la nostra coscienza è terribilmente rigida e tende ad identificarsi completamente con la propria sofferenza. Il depresso sente di essere la depressione invece di riconoscere che si tratta di una personalità colpita dalla depressione ma che si caratterizza anche in tanti altri modi. Pirandello dimostra di capire fin troppo bene la psicologia del nevrotico che spesso è così attaccato (quasi affezionato) alla propria nevrosi da ostacolare i movimenti della psiche che lo porterebbero a superarla e ad uscirne. Il senso dell’umorismo ammorbidisce la coscienza e trasforma la rigidità in flessibilità, permettendoci di vivere ciò che Koestler ha chiamato una ‘bisituazione’: siamo pienamente dentro e fuori allo stesso tempo (Koestler 1975 in Berger 1999, p. 103).
Il filosofo francese Henri Bergson, nel suo saggio sul riso (1901, p. 199), insiste su un punto essenziale: il senso dell’umorismo porta con sé dei chiari vantaggi cognitivi. L’umorismo ci permette di capire di più, di essere più intelligenti e di cogliere la complessità della vita in modo originale e sempre più umano. Ribalta il tragico, come quella terribile situazione che vive lo iettatore Chiarchiaro nella storia La patente (Pirandello 2007, vol. IV). Chiarchiaro si rivolge all’avvocato per fare causa a dei ragazzi che l’avevano offeso, dandogli dello iettatore in pubblico. Ma non fa causa per proteggere la sua reputazione o per una questione di dignità. La causa legale diventerebbe per questo povero uomo (vittima delle cattive opinioni – delle proiezioni – che gli altri hanno di lui) un’occasione per avere una patente, un riconoscimento ufficiale di ciò che gli altri gli attribuiscono. In questo modo la potrà usare a proprio vantaggio. La patente confermerebbe il male che egli è in grado di provocare e tutti sarebbero disposti a pagarlo pur di tenerlo lontano dalle loro case o dai loro posti di lavoro. Un gran bel ‘vantaggio secondario’, diremmo noi.
Molti autori – da Schopenhauer (Jung 2006, vol. III p. 47) che considerava l’umorismo l’unica qualità divina che posseggono gli esseri umani, al già citato Peter Berger, agli esponenti della scuola della psicoterapia esistenzialista (Rollo May, Irvin Yalom) – vedono nell’umorismo un’apertura alla trascendenza (May 1969, passim). Persino Freud, pur non utilizzando il termine trascendenza come fa Jung, riconosce che i meccanismi che danno vita e forma ai nostri sogni sono simili ai meccanismi che stanno dietro ai motti di spirito. Motto di spirito e sogno, quindi, come due aperture ad una visione diversa della vita rispetto alla posizione dell’io.
Il povero Bobbio (Pirandello 1954, p. 622) che nega che il suo terribile mal di denti possa essere passato grazie a quell’Ave Maria che gli era scappata, è l’emblema dell’uomo moderno con il suo razionalismo e il suo (nostro) mito della scienza. Nonostante il mal di denti gli passi anche una seconda volta dopo la recita di una preghiera, Bobbio, con un gesto buffo e quasi grottesco, è disposto a farsi togliere tutti i denti pur di dimostrare che Dio, in tutta questa vicenda, non c’entra. Pirandello di nuovo si dimostra fine psicologo. Il nostro Bobbio, conosciutissimo notaio nel suo paese di Richiere, era «ormai senza fede e scettico ma aveva tuttora dentro – e non lo sapeva – il fanciullo che ogni mattina andava a Messa con la mamma» (ivi p. 630). Dove è la compattezza e la coesione della personalità? Pirandello ci fa notare che agisce spontaneamente una spinta archetipica proveniente dal bambino divino, dal puer aeternus che permette alla coscienza di aprirsi nuovamente al senso della meraviglia delle cose e credere persino nei miracoli! L’assurda incongruenza del Bobbio illustra bene quanto sia dannoso per noi perdere il contatto con gli aspetti della nostra psicologia che vanno ben oltre i limiti della coscienza.
Concludo con una breve citazione di Peter Berger:
il mondo disincantato e dichiaratamente razionale dell’epoca moderna genera anch’esso delle incongruenze […] fino a quando l’uomo moderno potrà continuare a ridere di se stesso, la sua cacciata dai giardini incantati dei bei tempi andati non potrà dirsi compiuta. La nuova sensibilità umoristica potrà rivelarsi il tallone d’Achille della modernità come pure la sua possibile ancora di salvezza (Berger 1999, p. 308).
Bibliografia
- Berger P.L. 1999, Homo ridens. La dimensione comica dell’esperienza umana, Il Mulino, Bologna. Bergson H. 1901, trad. Il riso: saggio sul significato del comico, Laterza, Bari 1989.
- Jung C.G. 1929/1957, Commento al ‘Segreto del fiore d’oro’, in OCGJ, vol. 13°, Bollati Boringhieri, Torino 1988.
- Jung C.G. 2006, Lettere – vol. I, II, III, Edizioni Magi, Roma.
- Jung C.G. 1934-1939, Nietzsche’s Zarathustra: notes on the seminar given in 1934-39, Routledge, London 1988.
- Jung C.G. 1930-1934, Visioni: appunti del seminario tenuto negli anni 1930-34, Edizioni Magi, Roma 2004.
- Koestler A. 1964, L’atto della creazione, Astrolabio, Milano 1975. May R. 1996, Love and Will, Putnam, New York.
- Pirandello L. 1908, L’umorismo, Garzanti, Milano 1934. Pirandello L. 1954, Novelle per un anno, Mondadori, Milano.
- Pirandello L. 2007, Tutte le novelle, voll. I-V, Biblioteca Universale Rizzoli, Milano.
- Pirandello L 1925, Uno, nessuno e centomila, Einaudi, Torino 1994.
- Von Franz M-L. 1994, Archetypal Dimensions of the Psyche, Shambhala, Boston 1997.
- Von Franz M-L. 2010, Rispecchiamenti dell’Anima: Proiezione e raccoglimento interno nella psicologia di C.G. Jung, Vivarium, Milano.
Scarica il PDF
- Pirandello ridens – Robert Mercurio • 181 kB • 186 download
